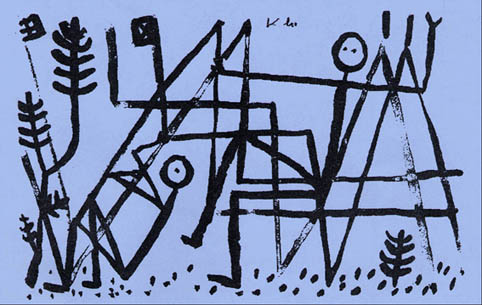
Pubblicato in Quaderno CespBologna n. 1: La scuola: prove di resistenza. Settembre 2002
Atti del seminario di auto-aggiornamento tenuto il 16 maggio 2002 presso l’ITIS Belluzzi di Bologna. A cura di Gruppo Scuola del Bologna Social Forum e CESP – Centro Studi per la Scuola Pubblica, Bologna
L’intento di questa relazione è analizzare la componente del potere all’interno delle relazioni scolastiche. La categoria potere può essere letta nel senso più istituzionale, intendendo per il controllo che dall’alto viene posto sull’istituzione scolastica, sotto forma di finanziamento, di normative e di controlli. Ma esiste anche una componente più larvata di potere, che si estrinseca nelle relazione tra persone (e le persone, almeno per il momento, sono al centro del rapporto educativo). È di quest’ultimo aspetto che intendiamo occuparci. Attraverso la scuola non si assimilano solo nozioni e contenuti, ma soprattutto si impara a imitare una struttura. Le indicazioni subito assimilate sono quelle di comportamento: non è un caso che l’istruzione sia sempre stata considerata una forma di educazione attraverso cui far assimilare modelli comportamentali: da questo punto di vista, la presenza di una relazione intesa come scambio tra persone o come imposizione di gerarchia ha una ricaduta fondamentale.
Qualsiasi insegnamento può configurarsi come una forma di potere, poiché presuppone, come elemento fondante, un dislivello tra l’insegnante e l’alunno: un dislivello che aumenta se l’inse-gnante interpreta il proprio ruolo come quello di vero e proprio maestro. Una qualsiasi forma di insegnamento pone un adulto a stretto contatto con dei discenti per molte ore al giorno: l’educatore è necessariamente una figura importante nella vita del ragazzo, che sempre vi vede un modello positivo o negativo; qualsiasi relazione educativa comporta una trasformazione mentale (acquisizione di nuovi strumenti cognitivi; autocontrollo; eliminazioni di stimoli o di procedure che non sono adeguate al rapporto con l’altro) di chi è sottoposto, parzialmente privo di strumenti di indagine o di difesa.
Il dislivello in quanto tale non è potere; non è negativo o positivo; la sua ricaduta dipende dal-l’impostazione che globalmente viene data alla relazione.
Perché il dislivello non diventi gerarchia ma rimanga il presupposto dell’insegnamento, è innanzitutto essenziale che si parli di formazione autonoma del soggetto, e non di educazione. Intendere l’insegnamento come educazione significa plasmare una mente “vergine”; il rischio è quello di un’onnipotenza da parte dell’inse-gnante. Deve invece restare centrale nel rapporto il ruolo del discente che impara, avendo in questo processo in questo la guida dell’insegnante.
Il dislivello dovrebbe essere sempre posto come dislivello di competenze e non di autorità: a queste condizioni è professionale, ed è la base di ogni buon insegnamento.
Gli obiettivi cognitivi, le competenze trasversali che si vanno acquisendo, dovrebbero quanto più possibile esser resi espliciti. Solo così il ragazzo ha consapevolezza di quello che fa, solo così non gli sembra arbitrario che si proceda in un modo anziché in un altro, solo così la motivazione è reale e non imposta o simulata.
Altra spinosa questione è il nodo dell’obiettività. A questo proposito è emblematico il caso dell’onorevole di Forza Italia Garagnani, che nell’anno scolastico 2001/2002 si è distinto per zelo censorio, con un “telefono amico” cui era possibile denunciare anonimamente professori connotati in senso antigovernativo (ma anche Storace, un anno fa aveva aperto, con modi perlomeno discutibili, una polemica sulla pretesa faziosità di libri di testo, manuali di storia che insistevano con particolare accanimento sui crimini di fascismo e nazismo).
L’insegnante non può censurarsi: esprime necessariamente una visione del mondo, come, a proposito dell’obiettività storica, ci viene trasmesso da studiosi come Carr o Marc Bloch. La pretesa asetticità dell’insegnante è in realtà un falso ideologico; dietro all’assenza apparente di valori non alberga un’assenza di giudizio, ma la pretesa di imporre i propri come Valori, in senso assoluto. Rispetto al posizionamento dell’insegnante, all’interno di una corretta relazione educativa esistono garanzie, che la scuola attualmente contiene. Non si tratta certo di tribunali o di censure: garanzie ben più valide sono, a tale fine, la pluralità delle voci, la correttezza scientifica del metodo (che deve essere trasparente ripercorribile, giustificato in sé), la possibilità, su interpretazioni, di discutere collettivamente; il rifiuto di qualsiasi posizione discriminatoria o razzista (a questo proposito esiste anche la possibilità di sanzioni e lo statuto degli studenti prevede la possibilità di istituire organi di garanzia interni, elettivi e trasparenti).
In futuro il crescente spazio dato alla Morale (quella cattolica), al voto di condotta come possibile debito formativo, alla sfera religiosa tra le competenze fondamentali da acquisire nella crescita, modificheranno questi scenari, e sulla libertà di insegnamento sarà di fatto esercitato un controllo, di tipo censorio se non addirittura preventivo. In ogni caso, formare dall’alto e in modo livellante la mentalità delle persone è una forma di potere, che si tratti di negare la memoria storica, o di propagandare imperativi morali dominanti, come la nuova filosofia di marca aziendalistica che fa il suo trionfale ingresso nel mondo educativo.
La relazione tra studenti e insegnanti presenta spesso aspetti di potere, che appaiono in forma abbastanza evidente anche a chi è esterno. Ogni tipo di relazione educativa può essere impostata in maniera gerarchica o dialogica, e dall’impostazione iniziale, dal primo impatto con l’ambiente educativo dipende molto del futuro scolastico.
L’imposizione del potere sullo studente si realizza con vari strumenti, l’uso della disciplina; l’uso sanzionatorio della valutazione , spesso recepita come un giudizio di valore espresso sulla persona. Il potere è inteso in forma punitiva o come deterrente, imposto attraverso la minaccia di sanzioni , soprattutto in rapporto al ruolo della famiglia, per cui il voto, o lo status scolastico diventa monetizzabile, merce di scambio per concedere/ottenere libertà.
Una relazione educativa impostata in termini di potere è in genere il metodo prediletto degli insegnanti che non sono disposti a mettersi in discussione e a considerare il rapporto con gli studenti come un rapporto multidirezionato, di interscambio e di dialogo (non è retorico affermare che lo studente può ricevere ma anche offrire molto al suo insegnante, in una ricchezza di punti di vista e di interpretazioni che arricchiscono entrambe le parti). Si ha così la sensazione di gestire perfettamente “il campo”, dominandolo dall’alto; idea illusoria perché si arriva sempre, inevitabilmente, al punto di rottura, in cui la deterrenza e la minaccia non incutono più paura. È il momento in cui, simbolicamente, qualcuno scavalca il limite; non è di per sé un fatto positivo o negativo: dipende da cosa si è posto come limite, la libertà di pensiero o quelle regole minime di convivenza, che proprio perché importanti, andrebbero condivise, non imposte.
L’ingestibilità culmina nello scontro diretto o nella totale “deposizione” dell’insegnante “tiranno” solo in casi-limite, quando la situazione presenta particolari conflitti latenti, un pregresso di scolarizzazione scarsa o nulla, un contesto sociale per cui il prestigio si determina valori diversi dal successo scolastico, come la capacità di imporsi a propria volta come leader.
L’ingestibilità tuttavia, in forme più larvate, tende a manifestarsi sempre, anche se non al punto da impedire il lavoro di classe. Di fronte ad una gestione in termini di potere le reazioni più frequenti sono la sottrazione e la frammentazione (sparisce la solidarietà di classe, tutt’al più è presente uno spirito di corpo che rende possibile la fuga e la sottrazione individuale).
Il rapporto di potere tende ad essere assimilato e riproposto all’interno della vita scolastica, anche tra gli studenti, nella classe o tra studenti di età diverse.
In queste situazioni di ingestibilità latente, dietro un ordine apparente, il danno emerge alla lunga e si manifesta nell’impreparazione, nell’immaturità della classe a gestire le proprie scadenze, nel-l’incapacità di vivere il lavoro scolastico in termini di crescita collettiva. Se viene imposto il valore della fatica, la reazione è il rifiuto del lavoro, intendendo per fatica lo sforzo gratuito e inutilmente quantitativo, per lavoro lo sforzo direzionato e consapevole.
Tra studenti si ripropongono frequentemente dinamiche di gerarchia e di potere, soprattutto in condizioni di disagio, in cui la gerarchia è stata già introiettata come la modalità dominante. Si tratta di dinamiche ancora più larvate, spesso difficili da interpretare per chi ne è esterno, perché codificate nel linguaggio dell’embrionale società del gruppo.
Il potere si esplica nelle relazioni individuali e nel successo personale, che è moneta nei rapporti umani, spesso dipendente da fattori che con la scuola hanno poco a che vedere. La scelta diventa tra integrazione ed esclusione, tra indifferenza e capacità di accogliere, tra aggressione (verbale, fisica, comportamentale: ti faccio sentire trasparente) e inclusione (spesso livellante e uniformante).
Il potere può anche servirsi del rapporto con l’insegnante, visto come erogatore di riconoscimenti e sanzioni sociali: nelle cariche, da quelle non scritte di capoclasse (premio simpatia del “cocco del prof”) a quelle elettive e ufficiali, qualora non siano vissute come un servizio e una forma di democrazia, ma come un fattore di prestigio personale.
In genere, quando l’adulto è colui che attribuisce il potere o ne è mediatore, il dislivello si fonda sulla facoltà di “parlare con chi può, con chi ha il potere”, e costituisce differenza rispetto ai compagni meno loquaci, meno brillanti, meno bravi.
In genere il primo modello di gestione autoritaria è quella familiare: spesso è il genitore che vive come valori l’idea di farsi valere o farsi strada. In questo senso le responsabilità non ricadono solo sulla scuola, che in alcuni casi si trova invece nel faticoso, quasi impossibile tentativo di decostruire un modello di relazione già sedimentato.
Ancora una volta, non è necessario che queste modalità emergano a livello patologico, nella maggior parte dei casi sono presenti in modo larvato e sotterraneo: non esiste gruppo classe in cui non ci sia il ragazzo antipatico a tutti, emarginato o considerato strano; non esiste classe che non abbia il suo alunno saputello, che si fa vanto della capacità di “giocarsi i professori”.
Smontare questi atteggiamenti è necessario: smontarli, proprio in senso letterale, scardinando la modalità educativa. Non è mai un’operazione sensata limitarsi ad invertire il segno del giudizio, che in genere si consolida per reazione (ad esempio, lodare il ragazzo che tutti trattano da scemo; o umiliare davanti agli altri quello che si sente una spanna sopra gli altri). Si tratterebbe infatti di imporre una valutazione diversa, non di uscire dal meccanismo che crea potere. Evidentemente, non bisogna creare gerarchie, ma usare come strumenti alternativi il confronto e l’auto-ironia (che è un ottimo esercizio educativo, insegna a non prendersi sul serio e a scoprire in maniera non traumatica il confine tra lo scherzo e l’offesa).
L’educazione autoritaria può anche diventare uno scontro di giurisdizione tra famiglia e scuola, se confliggono modalità educative fortemente diverse: lo scontro può avvenire tra una scuola autoritaria e un genitore che non condivide questa impostazione; oppure è il genitore autoritario ad essere posto in crisi dalla diversità di stimoli e idee che la scuola fa incontrare al proprio figlio. Da parte della scuola diventano armi le sanzioni, e nella massima tensione è il ragazzo a pagare questo scontro, subendo attacchi frontali, una valutazione che finisce sempre per essere condizionata, oltre che un clima difficile da sostenere. Dal canto suo, la famiglia può usare il rapporto di autorità per contrapporsi alla scuola, o contestare la scuola sulla valutazione che dà del figlio. In genere, oltre alla tensione questo provoca uno scollamento notevole, un’assenza di punti di riferimento e una tendenza ad allearsi con la parte più forte. È importante chiarire che lo scontro non è il necessario prodotto di due diverse visioni del mondo; se non si ha la pretesa di imporne una unilateralmente, questa divergenza può anzi essere vissuta come un valore in positivo.
Altri aspetti possono dar luogo allo scontro o al dislivello di potere. Non sempre il genitore è in grado di chiedere conto agli insegnanti del loro lavoro, anche quando questo presenta delle pecche; gli insegnanti fanno quadrato. La situazione si presenta, rovesciata, quando è il genitore che difende polemicamente l’assenza di studio o un comportamento “deviante” del figlio – in questo senso sono spesso i famigerati compiti a casa il terreno di scontro: si può dire insomma che le due realtà si chiudono a riccio l’una verso l’altra.
Si tratta allora di definire quale sia la competenza della scuola, quale quella della famiglia; il nodo acquista una rilevanza centrale rispetto al progetto di scuola che si sta configurando, in cui alla scuola si demanda una “educazione” in senso forte, compresa anche di scelte e di modelli valoriali, e alla famiglia si attribuisce un ruolo di cliente, e un crescente potere di sanzione e di “scelta”, ma si limita invece la reale possibilità di partecipazione e di condivisione di un percorso educativo.
Anche tra docenti la gerarchia è quasi sempre presente, più o meno visibile. I fattori sono variabili, si tratti di anzianità, prestigio, affinità di vedute con il preside, o anche di competenze riconosciute e certificate.
Nei primi anni è difficile per lo studente averne piena consapevolezza; più avanti invece si impara a fare leva proprio su questo, selezionando opportunamente i docenti forti, su cui bisogna fare affidamento e quelli deboli, le cui lezioni possono essere tralasciate. Anche in questo caso, vi è una gradualità con cui il potere si manifesta e, quando il potere diventa smisurato, le conseguenze sono pesanti: la prima è l’incapacità a svolgere un lavoro collegiale. La materia diventa un feudo di esclusiva proprietà del docente, che mira o ad affermare il proprio metodo in maniera esclusiva e totalizzante, o a difenderlo dall’espansione tentacolare dei colleghi. Ma alla fine, viene meno la solidità dell’intero edificio educativo: se non ha valore un singolo insegnamento, nulla può motivare profondamente gli altri – se non la costrizione.
Questa relazione, malgrado i toni quasi catastrofici, si pone solo l’obiettivo di ritrarre alcuni meccanismi diffusi, che informano ogni tipo di relazione autoritaria; ma il concetto di gradualità, nel manifestarsi di queste dinamiche, è fondamentale. Nella scuola italiana non esistono solo esperienze autoritarie; ma la presenza latente di queste ambiguità è più diffusa di quanto non si creda. Nella scuola, la categoria del potere, a differenza di tutte le altre, ha solo una valenza negativa: non esiste un potere utile, o buono; per questo, metterne a nudo i meccanismi fondanti è anche un obiettivo operativo, da riportare nella realtà quotidiana. La generalità delle situazioni si attesta su un livello di gerarchia, del semplice dislivello di competenze o di potenzialità, che però resta vagamente ambiguo. Ogni dislivello non motivato è potenzialmente pericoloso, e porta all’acquisizione di un’impostazione mentale che dà spazio alla gerarchia, attraverso una visualizzazione verticale dell’apprendimento, dall’imperfetto al perfetto, dal vuoto al pieno.
Più limitato è il vero e proprio autoritarismo, l’impostazione educativa che della gerarchi fa un valore, una metodologia fondante.
Il potere è qualcosa di ancora diverso, che si configura come un vero e proprio abuso delle potenzialità offerte dal dislivello iniziale; ciò che distingue il potere è la mancanza di trasparenza, l’impossibilità di chiedere spiegazioni, e la minaccia, o il timore, di ritorsioni: al punto che chiedere spiegazioni diventa spesso qualcosa di impensabile, perché si decide in base a leggi non scritte, e sparisce la sensazione di avere dei diritti.
Anche tenendo chiara questa gradualità, resta il fatto che uno studente al termine del suo percorso educativo e formativo spesso ha imparato che nella vita, nel suo futuro, nel suo posto di lavoro, dovrà essere preparato a tollerare tanti piccoli esempi di potere, tante piccole decisioni immotivate. “Sai quante volte ti capiterà…” è una delle espressioni più comuni in un percorso scolastico. A questo proposito, assumono rilevanza i modelli alternativi, gli esempi di possibili vie d’uscita, realizzabili senza doti particolari; anche l’esempio di un compagno diverso, che rifiuta la deterrenza, o la competizione, può trasmettere qualcosa, quantomeno l’idea che si può.
E importante mantenere vive le esperienze educative diverse, per sottrarsi all’uniformità di un modello, che, prima su un’eredità gentiliana, ora su una mistificazione aziendalistica e professionalizzante, imponeva e impone modelli gerarchici. Il mantenimento di spazi critici, il continuo ricorso alla diversità degli strumenti, alle modalità del lavoro collettivo, in cui, più che il travaso di competenze dal più bravo al meno bravo viga la regola dello scambio, e, ancora l’abitudine al dialogo e all’ascolto reciproco fin da piccoli, sono tutti esempi di un modo diverso di fare scuola; un modo antigerarchico di insegnare (e in quel prefisso anti- sono racchiuse tutta la conflittualità e la politicità che si esprimono nella ricerca di un’alternativa). Abbiamo bisogno di una scuola di pensiero critico; ed è importante che queste esperienze non siano caratteristica di isole felici, spazi liberi al loro interno, ma rigidamente confinati e autoreferenziali. Applicare questa modalità antigerarchica di scambio all’intero sistema scolastico è una forma di resistenza sociale e, oggi, costituisce il modo più efficace per continuare a difendere, anzi, estendere il diritto a un’istruzione libera e democratica.

Nessun commento
I commenti sono chiusi.